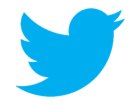L’approvazione della legge sul suicidio assistito da parte del Consiglio regionale della Toscana ha consentito di dare di nuovo rilievo pubblico ad una questione delicatissima sul piano etico e politico, rispetto alla quale è forte la tentazione di assumere posizioni di assoluta rigidità. E tuttavia, già la sentenza della Corte Costituzionale su questa materia ha delineato la necessità di farne l’oggetto di una specifica legislazione. Rispetto a questo scenario non è pensabile alcuna opzione che tenda a preservare lo status quo o a rimandare sine die un confronto che, prima ancora che nelle aule parlamentari, necessita di articolarsi sul piano della discussione pubblica.
Lo sforzo di portare il dibattito sul terreno di una discussione più diffusa e radicata nella coscienza civile del paese è la via che consente di evitare una serie di rischi che possono prodursi tanto sul terreno etico quanto su quello politico. A cominciare dalla tendenza a ridurre il tema del fine vita a quello del suicidio assisto. Quanto la Consulta chiede di normare è infatti un aspetto del più vasto problema del rapporto con la sofferenza e la malattia, soprattutto con la malattia nella sua forma più acuta e irreversibile. E tale questione non è confinabile nella sola dimensione privata, dal momento che il dolore del corpo interroga alla radice la dignità della persona, cioè tocca un punto che ha un rilievo anche politico. Serve prendere atto dell’esistenza, su questo argomento, di sensibilità diverse nel tessuto sociale e culturale del nostro paese, le quali devono essere messe nella condizione di poter intessere un dialogo nella reciprocità.
Per i cattolici italiani, accettare la fatica di questo confronto non significa fare un passo indietro. È piuttosto un fare, tutti assieme, un passo avanti per cogliere un’occasione che è quella richiamata anche dall’elaborazione conciliare, che rinunciava all’idea di utilizzare le leggi dello Stato come strumento di evangelizzazione. Un elemento, questo, che di fronte a un tema potenzialmente divisivo e certamente lacerante sul piano della coscienza, aiuta a muoversi in uno spazio di libertà: quello di chi sa ascoltare e sa pronunciare una parola maturata alla luce di una ricca esperienza di umanità. Diviene così possibile operare per dare valore al carattere plurale della nostra società, facendone non la cifra di un relativismo che diviene indifferentismo, ma piuttosto terreno ricco, su cui edificare una riflessione etica che sia patrimonio di tutti e che si rispecchi, alla luce della Costituzione, in cornici normative appropriate. E del resto è solo così che possono essere valorizzate quelle posizioni e non sono poche che, anche fra quanti non si riconoscono nelle istanze etiche animate dalla fede, sentono e cercano un punto di incontro e di dialogo. Sono le voci che hanno contribuito a redigere un prezioso documento della Consulta Scientifica del Cortile dei Gentili e che vogliono creare le condizioni perché Su una materia così delicata, avere fiducia nel processo democratico significa prima di tutto invitare ognuno, credente o no, ad assumere la disposizione di chi cerca la verità e che sa che questo cercare non può mai essere senza l’altro. È questo il metodo con cui è possibile dare respiro ad un percorso che diviene fatto comunitario, che impegna noi e l’altro e che mette in gioco nel modo più fruttuoso la sensibilità che i cristiani hanno per una visione integrale della vita umana.
Ecco allora l’esigenza che sia il Parlamento a riguadagnare il ruolo di protagonista, a partire dai numerosi disegni di legge già presentati, come quelli Bazoli. È questa istituzione che ha il compito di farsi carico di un’elaborazione che agisca quale strumento di crescita della coscienza civile e morale del paese. È in quella sede che il processo democratico può trovare la sua compiuta forma di dinamica inclusiva, che ci riporta al nostro essere cittadini. Di fronte ad un tema come il fine vita la scelta coraggiosa di dare consistenza ad un discorso etico e civile in cui tutti possono riconoscersi è un’occasione per far sì che credenti e non credenti possano prendersi cura insieme della dignità dell’essere umano, in un esercizio autentico di libertà.