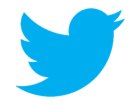La memoria della Resistenza, proprio nel suo 80° anniversario rischia di finire soffocata da polemiche strumentali o di scivolare nel dimenticatoio del “già visto”. Mai come oggi, invece, è una memoria preziosa per la nostra identità culturale e civile di italiani e di europei, necessaria per orientarci in un futuro incerto. Questo vale anche per i cristiani, il cui contributo alla liberazione fu molto importante, ma è poi passato in secondo piano, quando non del tutto ignorato, specie dalle nuove generazioni di adulti e giovani, che non hanno avuto contatti diretti con quel periodo e con i suoi protagonisti.
IL CONTRIBUTO DEI CATTOLICI ALLA RESISTENZA
In Italia, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, il conflitto diventa guerra civile e molti cattolici e parte del clero aderiscono alla «resistenza non armata». Non solo in Piemonte la durezza dei rastrellamenti, la violenza dei nazifascisti contro i partigiani e la latitanza degli amministratori civili creano un clima di incertezza e paura.
Tanti parroci e tante suore e religiosi restano nelle comunità locali tra i pochi riferimenti della popolazione, svolgendo una delicata e pericolosa funzione di protezione degli abitanti e dei soldati sbandati, spendendosi nell’opera di mediazione con gli occupanti nazisti e i fascisti di Salò. Non mancano poi i casi di una partecipazione diretta alle formazioni partigiane e di un sostegno all’azione dei CLN; numerosi sono i giovani e le giovani provenienti dalle associazioni di AC che fanno la scelta partigiana o collaborano direttamente con i partigiani.
IL RUOLO DELLE DONNE
Gli studi storici e le memorie individuali ci hanno lasciato molte tracce, testimonianze e documenti della lotta di Liberazione. Solo di recente ed ancora parzialmente si è approfondito il ruolo delle donne nella Resistenza: tutti i protagonisti diretti ne esaltano l’importanza, ma nella memoria collettiva (e per parecchio tempo anche nella storiografia) esse sono rimaste ai margini. Ha pesato indubbiamente una “visione al maschile”, anche perché ci si è maggiormente concentrati sulla lotta armata (alla quale peraltro le donne non furono estranee) mentre si è dato minor rilievo a tutte quelle forme di “resistenza” non direttamente legate ad azioni militari o di guerriglia, ma che sono state decisive sia per sostenere i partigiani, sia per svolgere quell’azione di comunicazione, assistenza e protezione verso ebrei, ricercati, sfollati, ... sia per costruire un giudizio - morale prima ancora che politico - di opposizione al nazi-fascismo. Emblematica la vicenda degli IMI, Internati Militari Italiani nei lager nazisti, che in grande maggioranza seppero dire NO alla Repubblica Sociale di Mussolini/Hitler.
DALL’ANTIFASCISMO DI FRASSATI
Una “scarsità” di memoria che per diversi motivi ha riguardato anche il contributo dei cattolici alla Resistenza. Un contributo che si dilata nel tempo, riguardando l’antifascismo che ha caratterizzato ampi settori del mondo cattolico negli anni ’20 e ’30, e il ruolo svolto dai cattolici nella nascita della democrazia italiana, dal cosiddetto ‘codice di Camaldoli’ alla partecipazione alla lotta di Liberazione, dall’impegno per le elezioni amministrative e poi per quelle della Costituente nel 1946, al determinante contributo dato per la elaborazione della Costituzione.
Quest’anno in particolare, è significativa la coincidenza dell’80° anniversario della Liberazione dal nazi- fascismo con la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati. Frassati intuì fin dai primi anni ’20 la pericolosità del fascismo e la sua incompatibilità con la visione cristiana. Morì giovanissimo nel 1925, proprio mentre il fascismo si stava trasformando in regime, segnando la fine del sistema liberal-democratico in Italia, ed avviando un processo che si sarebbe allargato a macchia d’olio in molti paesi europei. La sua testimonianza fu però determinante nella formazione delle successive generazioni di giovani cattolici. Ciò sollecita ad una riflessione sul senso attuale di questa memoria e sul ruolo dei protagonisti. Tanto sul piano civile quanto su quello ecclesiale.
... ALLA SCELTA PARTIGIANA DI GIORGIO CATTI
Per questo l’Azione Cattolica di Torino e del Piemonte/Valle d’Aosta (con la collaborazione del Centro “G.Catti”, MEIC, ANPC, ANPI, Circoscrizione 2 e Comune di Torino) hanno ritenuto opportuno riprendere la memoria di Giorgio Catti1, giovane partigiano militante dell’Azione Cattolica di Torino, ucciso dai fascisti nel dicembre 1944. Catti, come tanti della sua generazione, maturò la sua vocazione cristiana sulle orme di Pier Giorgio Frassati, divenuto fin da subito, dopo la sua improvvisa morte nel 1925, un riferimento ideale per i giovani cattolici.
Tanti i temi che si intrecciano in questo soffermarsi sulle figure di Frassati e di Catti: dalla ricerca di fede alla sua testimonianza nel proprio tempo, dal rapporto tra formazione etico-religiosa e impegno politico, dai gesti rischiosi di solidarietà ed assistenza al nodo dell’uso
della violenza/non violenza nella lotta politica, dal giudizio sulle guerre di ieri, all’atteggiamento verso le guerre di oggi (“sante”, giuste, legittime, sbagliate, inutili, castigo o purificazione ...), fino alla domanda sul senso attuale dei testimoni di santità per gli adulti, i giovani, i ragazzi.
Dalle testimonianze affiorano significativi tratti del contributo dei cattolici alla Resistenza, nei vari modi di partecipare ad essa. Emerge la difficoltà, specie dei più giovani, cresciuti dentro al regime fascista che si trovano a operare una scelta antifascista, decisiva e pericolosa. Proprio in questa difficoltà affiora la centralità della dimensione spirituale sottesa a tanti sacrifici e rischi, fondamentale ma spesso sottaciuta o ignorata dalla storiografia; così come si evidenzia il ruolo rilevante della Chiesa e dell’associazionismo cattolico che – proprio in frangenti drammatici di smarrimento e confusione – fornì alle persone riferimenti e strumenti di comprensione e azione. Anche questa è una lezione preziosa per l’oggi.
QUALE MEMORIA OGGI?
Un percorso che collega quindi strettamente quelle generazioni e giunge fino ai giorni nostri. Infatti, si tratta di una memoria radicata nella storia del nostro paese, in modo particolare nell’Azione Cattolica e nella comunità ecclesiale, ma che è poco conosciuta e ancor meno considerata nella formazione di un giudizio storico e politico. Oltre la retorica, la nostalgia, occorre riproporre tale memoria: non per un desiderio di rivendicare e competere con altre memorie (ben sappiamo che la Resistenza fu un fenomeno complesso e pluralistico, ma anche animato da una ricerca di unità), bensì perché essa è una eredità attuale, capace di offrire molteplici spunti di riflessione sul presente e sul futuro. La distanza e diversità dei contesti rispetto a quelli di 80 o 100 anni fa è evidente: questo ci evita paragoni frettolosi e approssimativi, ma insieme ci pone di fronte a meccanismi culturali e politici che paiono ripetersi, toccando la fecondità della fede e la vitalità della democrazia. E mettendole in discussione.
DALLA RESISTENZA ALLA COSTITUZIONE
La memoria e il sacrificio di quanti parteciparono alla Resistenza ci aiuti a salvaguardare e promuovere l’attuazione del suo frutto più importante: la Costituzione.
In proposito – anche di fronte a dimenticanze e manipolazioni – è opportuno ribadire con chiarezza i motivi storici e culturali per i quali la nostra Costituzione – nata nella Resistenza e grazie alla Resistenza - è positivamente antifascista e – più ampiamente - antitotalitaria. Ossia la Costituzione non è semplicemente contro il fascismo, ma è contro quel regime e quella ideologia perché sceglie una visione alternativa, costruttiva, in una direzione opposta a quella del fascismo. Non sposa una ideologia specifica ma non è neutrale riguardo alla visione dell’uomo e della società: dignità, giustizia e uguaglianza vs. discriminazione e razzismo; democrazia partecipativa vs. autoritarismo/dittatura; dialogo e confronto vs. violenza come metodo di lotta politica e sociale; dialogo/diplomazia, cooperazione internazionale/pace vs. logiche di potenza/dominio/guerra; democrazia economica vs. potere incontrollato della proprietà, delle grandi imprese e della finanza; logica del bene comune e della solidarietà vs. visione individualistica ed esclusiva. Che tutto ciò sia di forte attualità è sotto gli occhi di tutti.