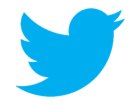Argomenti 2000 per la Toscana
I grandi traumi storici non sono qualificati da singoli accadimenti eclatanti: sono, piuttosto, l’esito di processi nei quali si intersecano attese, speranze, sofferenze e timori di carattere diverso che nel loro interagire costruiscono la trama e l’ordito della realtà. È difficile riuscire a cogliere quale potrà essere l’immagine di questo tessuto che si viene formando e che è l’umanità e il mondo di domani. E questo perché le donne e gli uomini, soprattutto nei regimi democratici, non sono i semplici fili da intrecciare fra loro, ma sono anche i tessitori, che scelgono quale consistenza, forza e delicatezza dare a quanto uscirà dal telaio. E tuttavia, la realtà che viviamo presente eventi, circostanze, processi che rivelano la portata dei cambiamenti, soprattutto quelli che si incarnano in un modo nuovo di guardare la realtà, di comprenderla e di sperare in essa.
Il primato della realtà
Nello sforzo di dare una lettura politica della realtà vi è un’opzione di partenza che è essenziale: quella per gli ultimi e i poveri. La politica pienamente democratica è prima di tutto consapevolezza che la condizione di chi è in difficoltà, di chi vede violati diritti e dignità, di chi affronta limiti e ostacoli alla possibilità di una vita buona è il punto di partenza dell’intera comunità. Quest’ultima infatti vive la dinamica democratica nella sua compiutezza solo quando è informata al principio della fraternità che significa una cosa sola: accettare il passo degli ultimi come passo della storia. Tutto questo è ancor più vero alla luce di questi ultimi sei mesi, segnati dalla prova radicale della pandemia. È qui, infatti, che si sono mostrate le fragilità e le fratture di parti vastissime dei nostri sistemi politici ed economici, delle nostre relazioni sociali; hanno mutato l’ordine delle priorità e costretto ad accettare il primato della realtà su ogni ideologia e su ogni programma che pretendeva di imporsi senza misurarsi con la verità delle cose. Le scelte operate in queste settimane dei governi europei e non solo sono il chiaro segno di una crisi profondissima di una idea, quella della forte contrazione della sfera pubblica e della responsabilità della politica, che per quasi quarant’anni si era affermata in ragione del primato dell’economia e del mercato. Questa svolta radicale non segna tuttavia il semplice ritorno al keynesismo degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso perché si accompagna con elementi di assoluta novità storica:
- Una diffusa sensibilità, soprattutto nel corpo sociale e culturale europeo e nordamericano, del valore pubblico della questione ambientale;
- La convinzione che la dimensione pubblica non coincida con la sfera di competenza dello Stato ma piuttosto con l’esercizio di una responsabilità diffusa e comunitaria;
- L’esistenza di uno spazio politico europeo che, se sul terreno istituzionale è ancora un processo incompiuto e non privo di criticità, si è dimostrato come la dimensione nella quale dare risposte efficaci e democratiche alle sfide di una navigazione in mare aperto;
- L’esistenza di una dimensione, quella digitale, che non è un veicolo comunicativo ma una parte ancora da scoprire della realtà di questo XXI secolo nella quale si forma e opera certamente l’opinione pubblica ma anche e soprattutto si dispiegano nuove relazioni lavorative, economiche, sociali e culturali dell’umanità;
- Il fatto che siano le generazioni più giovani ad essere portatrici di questi elementi che, pur non esenti da criticità e contraddizioni, tracciano il volto di una nuova cultura e di una nuova gerarchia di valori che non è più quella uniforme della globalizzazione ma quella plurale e multiforme dell’uomo planetario.
Le attese e le sfide della Toscana
Dentro questo contesto, le elezioni regionali del prossimo settembre segnano un passaggio politico e istituzionale che non può essere giocato in una logica di conquista del consenso che appartiene ad un’idea di democrazia limitata alla “delega” della volontà popolare a figure carismatiche o a gruppi ristretti di potere. La realtà, di cui anche la nostra Regione è parte, richiede di pensare l’esercizio del potere democratico come un processo, nel quale il momento elettorale è certo essenziale, ma nella misura in cui è parte di un cammino comune nel quale il consenso si forma e si costruisce attraverso la discussione, il confronto, lo scontro, la reciproca intelligenza. Perché è solo attraverso la fatica di questa costante pratica del metodo democratico, che si preoccupa di convincere più che di vincere, che una comunità esercita la responsabilità collettiva di una scelta che riguarda tutti e alla quale tutti hanno il diritto/dovere di prendere parte.
La Toscana ferita dal Covid-19 vede emergere le fragilità di una terra nella quale si sono accumulate crisi territoriali e impoverimento economico e sociale, ma si sono venute creando anche fratture profonde di ordine geografico, culturale e sociale che ora rivelano tuta la loro portata. La lunga e irrisolta crisi del distretto tessile pratese, le conseguenze economiche e sociali delle crisi di istituti bancari radicati nei territori – dal Monte dei Paschi a Banca Etruria –, la situazione di profonda sofferenza economica e ambientale dell’area delle Apuane, lo sgretolarsi di modelli politici e culturali di governo che si sono verificati in città come Livorno, Pisa e Pistoia, il respiro cortissimo di un’economia – quella fiorentina – da anni imperniata sul turismo di massa e sulla rendita che da questo deriva. Sono queste le tessere che compongono il ritratto di una vicenda politica che permette di capire le attese e che la Toscana ha davanti e dunque la vera sfida che attende la Regione: essere, prima ancora che soggetto istituzionale, spazio nel quale si costruisce un governo della realtà che è di tutti, per tutti e viene esercitato nella ricerca dell’interesse di tutti.
Darsi degli obiettivi
Occorre affrontare e superare le fratture che esistono: quella fra Firenze e le aree urbane limitrofe, quella fra la zona costiera e quella più interna, quella fra nord e sud della Regione, quella, profonda e diffusa, fra gli strati più ricchi e con più opportunità e i troppi che vivono la povertà delle periferie geografiche e sociali. Povertà che sono materiali ma anche culturali e che spesso si traducono in assenza di occasioni di una vita giusta e di possibilità di esercitare pienamente i diritti e i doveri che la Costituzione pone a fondamento della Repubblica. Quello con cui è imperativo confrontarsi è allora la realtà della Toscana come la dimensione socio-ambientale che abitiamo e di cui siamo tutti responsabili. Una responsabilità che deve mirare a:
- La cura delle risorse ambientali alla luce del principio di responsabilità;
- Lo sviluppo delle relazioni sociali ed economiche secondo un criterio di giustizia ed equità;
- L’attenzione costante alla cultura alla luce di una costante fedeltà al pluralismo delle idee, dell’intelligenza delle cose, delle fedi e delle convinzioni.
Sono questi i principi che possono permettere di leggere i processi storici che attraversano anche la Toscana e di governarli attraverso una prassi politica che esprime una piena maturità democratica.
Un metodo di governo
Questa maturità democratica necessita di esprimersi in un metodo fatto di alcune prassi essenziali, a cominciare da quella della costruzione del consenso, la quale è parte integrante di una concezione della Regione modellata sul principio di sussidiarietà integrale. Tale prospettiva, che mira a dare pina attuazione agli articoli 58 e 59 dello Statuto della Regione Toscana, impone di coinvolgere nelle scelte e nel governo della realtà tutti quanti sono direttamente coinvolti e dunque di investire energie e fiducia politica nella centralità delle istituzioni rappresentative, a cominciare dal Consiglio Regionale. Quest’ultimo, infatti, non può essere inteso come semplice luogo di approvazione di provvedimenti dell’esecutivo regionale: il suo essere luogo di esercizio della potestà legislativa e al contempo responsabile di determinare l’indirizzo politico e programmatico della Regione, ne fanno lo spazio istituzionale nel quale deve venire a piena maturazione la decisione politica, attraverso un dibattito e un confronto aperto alla pluralità di soggetti che formano la Toscana. Il Consiglio deve tornare ad essere il modello di un metodo di governo della nostra Regione fondato sulla discussione, la spiegazione, l’argomentazione, che portano a convincere e a maturare una decisione che porta in sé il contributo di tutti.
Il principio di sussidiarietà non deve essere inteso come un semplice criterio giuridico: esso è piuttosto la traduzione istituzionale di quel principio politico che è la fraternità. Questo comporta uno sviluppo della legislazione regionale e delle prassi di governo delle amministrazioni che sappia fare della fraternità il criterio non solo di cooperazione fra i diversi livelli istituzionali ma anche e soprattutto fra quelle reti di soggetti che condividono sfide, bisogni, necessità, speranze e progetti di futuro possibile. Si tratta dunque di dare piena attuazione alla legislazione regionale sulla partecipazione politica punto ad una dinamica di amicizia civica che vada al di là del piano istituzionale e includa in dinamiche virtuose le reti associative e i movimenti che a vario titolo vivono la loro esperienza e svolgono il loro servizio nel territorio della Regione e dei suoi comuni. Il bilancio regionale deve allora prevedere adeguati sostegni economici ad una politica che incrementi e favorisca la costruzione di queste reti di amicizia civica.
In questa logica di sussidiarietà diffusa che si fa fraternità occorre allora costruire livelli di maturazione della decisione politica ulteriori, a partire da una interlocuzione costante e istituzionalizzata fra Regione e ANCI Toscana, e favorire con adeguate azioni di coordinamento, la costruzione di reti di comuni per governare assieme quelle questioni socio-ambientali che sotto l’apparenza di interessi contrastanti rivelano l’esistenza di un bene comune da tutelare. Occorre allora utilizzare al massimo delle sue potenzialità lo strumento della Conferenza permanente delle autonomie sociali e del Consiglio delle autonomie locali (previsti rispettivamente dagli articoli 62 e 66 dello Statuto della Regione), perché la maturazione della decisione politica avvenga coinvolgendo e convincendo tutti gli interlocutori coinvolti nelle scelte da compiere.
Individuare provvedimenti di lungo periodo
Con questo metodo è possibile sviluppare un’azione di governo capace di costruire la Regione Toscana come luogo politico di governo della realtà di cui tutte le cittadine e i cittadini sono responsabili e che concorre alla vita italiana ed europea. Soprattutto, è con questo metodo che è possibile raggiungere il risultato più efficace e duraturo su alcune questioni cruciali per il futuro della Regione sulle quali avanziamo alcune proposte.
- La questione delicata e complessa della rete di infrastrutture toscane richiede scelte coraggiose e ancor più richiede scelte compiute nella logica della sussidiarietà integrale. La realizzazione dell’aeroporto fiorentino, l’infrastrutturazione ferroviaria della Regione, la soluzione dei decennali problemi della Strada a Grandi Corsie Firenze – Pisa – Livorno, della Superstrada Livorno – Grosseto, dell’Autopalio e della Siena – Grosseto, sono gli esempi più significativi di uno stato di cose che esige cambio di logica. A cominciare dal fatto che opere del genere non possono essere pensate nell’interesse di una parte o di una sola comunità ma, tanto nella progettazione quanto nella realizzazione e nella gestione richiedono un’assunzione di responsabilità dei soggetti pubblici che sono toccati e coinvolti. Vi sono modelli virtuosi che si possono adottare e adattare alla Toscana, come la società che gestisce l’Autostrada A22 del Brennero, che ha una larga maggioranza di capitale pubblico fatto dalle Regioni, province e dai comuni attraversati da questa infrastruttura, a cui si aggiungono soggetti privati che però, per le loro attività, partecipano dell’interesse pubblico di quei territori. È un modello capace di creare sviluppo e ricchezza e che potrebbe essere pensato per gestire in modo sussidiario la realizzazione e gestione delle infrastrutture regionali. Soprattutto, è un modello che potrebbe permettere di creare utili il cui investimento, oltre che alla manutenzione e al potenziamento delle infrastrutture, sia vincolato a progetti e azioni di compensazione dell’impatto ambientale determinato dalle grandi opere. Questa organizzazione del processo di realizzazione e gestione delle infrastrutture regionali consente di articolare il loro sviluppo dentro un quadro unitario sul piano della politica dei trasporti. Occorre infatti creare le condizioni per superare una visione dell’organizzazione dei trasporti consegnata da decenni agli interessi confliggenti delle diverse aree della regione e ad una impostazione che è apparsa troppo centrata sul capoluogo di regione. Lo sviluppo dell’aeroporto fiorentino non può che essere considerato dentro il quadro complessivo di una rete di trasporti che deve integrare anche lo scalo pisano, una rete ferroviaria all’altezza dei più avanzati standard europei in tutta la Regione (prevedendo il raddoppio e l’elettrificazione di tratti ancora oggi scarsamente sviluppati come la Siena-Empoli e la Siena-Grosseto), l’infrastruttura portuale di Livorno e la rete autostradale.
- La sfida di governare la Toscana in una logica di sostenibilità socio-ambientale esige di dotare tanto la Regione quanto la città metropolitana e i comuni degli strumenti istituzionali più adeguati. Un’apposita legge regionale dovrebbe allora recuperare e potenziare lo strumento del bilancio ambientale, facendone l’atto di indirizzo politico e finanziario di governo di comunità e territori. La capacità di questo strumento di restituire una visione complessiva della realtà e dei suoi diversi piani lo rende capace di superare le incongruenze di azioni di governo in cui troppo spesso la settorializzazione delle competenze politiche porta a non cogliere l’intreccio che, ad esempio, lega assieme ambiti come lo sviluppo economico, le opere pubbliche, l’urbanistica e l’ambiente. Il bilancio ambientale consente invece di pensare e governare lo sviluppo delle comunità regionali e locali e dei loro territori secondo una unitarietà politica che non rende tutto omogeneo ma, al contrario, sa distinguere, valorizzare e integrare la ricca pluralità di una terra come la Toscana e farne un punto di forza. Lo strumento del bilancio ambientale può inoltre fare della Toscana una realtà politica capace di stare al passo con gli obiettivi e alle attese di quel nuovo patto di sviluppo sostenibile che è il pernio della politica dell’Unione Europea per i prossimi decenni. La realizzazione di questo strumento è essenziale per permettere alla Regione e con essa ai comuni di articolare una strategia di lungo periodo di cura dell’ambiente. È solo combinando cura dell’ecosistema e delle risorse con le prospettive di sviluppo socio-economico dei territori, che sarà possibile introdurre alcuni ulteriori interventi strategici per lo sviluppo della Regione che mirano a inserire la Toscana del quinquennio 2020-2025 dentro il percorso ambizioso del piano di sviluppo proposto dalla Commissione Europea: (1) il varo di una legge regionale che dia una visione unitaria della formazione dei lavoratori e dell’istruzione professionale, capace di costruire un circolo virtuoso fra educazione professionale e sviluppo socio-economico dei territori e dei distretti della Regione che sappia unire l’esigenza di professionalizzazione con un alto livello di cultura generale e civica; (2) una adeguata gestione del bilancio della sanità che miri ad aumentare l’efficacia dei presidi territoriali, coordinando in modo più efficace il rapporto fra medici di base e strutture ospedaliere, ad incrementare l’aggiornamento scientifico, tecnologico e professionale del personale socio-sanitario, ad un costante controllo della qualità dei servizi resi dalle strutture toscane a tutela del diritto universale alla salute; (3) un forte incentivo al settore della piccola e media proprietà agricola e del turismo diffuso e sostenibile, questo al fine di dare un sostegno soprattutto alle aree ricche di cultura, bellezza e risorse che sono diffuse al di fuori delle grandi città d’arte della Regione; (4) un investimento di lungo periodo sul settore geotermico che in Toscana gode di una lunga tradizione; (5) un ulteriore sviluppo di fonti alternative di energia che sia ecocompatibile; (6) il varo di un progetto regionale per la gestione, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti, che si avvalga delle migliori tecnologie disponibili e contemporaneamente incentivi comportamenti e prassi sostenibili da parte dei cittadini; (7) il varo di un progetto regionale di riconversione della mobilità privata e pubblica che vada verso un progressivo passaggio a mezzi ecosostenibili (ad esempio le auto elettriche) che tuttavia richiedono una adeguata infrastrutturazione del territorio regionale.
- L’ambizione di rendere la Toscana una delle regioni guida della Unione Europea richiede la capacità della classe dirigente di saper pensare politicamente in chiave europea e al tempo stesso richiede una pubblica amministrazione in grado di sapere elaborare e realizzare progetti capaci di attingere alle risorse europee. Occorre allora che quest’ultima abbia, diffuse e presenti a tutti i livelli, quelle figure professionali capaci di tradurre in progetti e atti conformi agli standard europei la volontà politica di usare le risorse dell’Unione. Serve dunque che la Regioni aiuti i comuni toscani a dotare i loro organici di queste professionalità, investendo nella creazione di uffici “europei” affidati a personale adeguatamente formato e supportato tanto dagli uffici della Regione quanto dalla rappresentanza della Toscana presso l’Unione Europea. Questi uffici possono incrementare notevolmente la capacità della Regione di attrarre fondi dell’Unione e investire le risorse europee con efficacia e nell’interesse generale.
- La Toscana ha un potenziale di saperi, ricerca e innovazione di altissimo livello e tuttavia poco valorizzato sul piano regionale. Nonostante la presenza di tre fra i maggiori atenei italiani (Firenze, Pisa, Siena) e delle due principali scuole di alta formazione (Scuola Normale Superiore, Scuola Sant’Anna), dell’università per stranieri di Siena, nonché si cruciali istituzioni di ricerca di portata internazionale, esiste una sorta di iato fra la vita economica, sociale e culturale della Regione e questo mondo di saperi e della realizzazione di cultura umanistica, scientifica, socio-economica, giuridica, tecnica. Occorre dare spazio a questo significativo capitale di saperi per metterlo a vantaggio di tutti e al riguardo al Regione deve muoversi su un duplice binario. (1) Da un lato, deve favorire l’accesso del sistema industriale e manifatturiero delle diverse aree della Regione e dei suoi distretti industriali all’uso delle infrastrutture scientifiche dei poli universitari e di ricerca diffusi sul territorio. La possibilità di far confluire investimenti privati per sostenere la ricerca in settori come l’economia, le diverse tipologie di produzione industriale, l’innovazione tecnologica e informatica, nell’ambito biomedico, deve essere accompagnata e sostenuta, in modo da creare un circolo virtuoso fra la Toscana e i suoi centri di sapere. Serve al riguardo un’apposita legge regionale che incentivi, usando anche la leva delle fiscale delle addizionali regionali, questo genere di investimenti da parte dei soggetti privati e al tempo stesso offra tanto alle università quanto ai privati un adeguato supporto amministrativo e politico, ad esempio, nell’elaborare progetti che concorrono ai bandi europei dei programmi di ricerca integrando il tema della ricerca e dell’innovazione con quanto già indicato al punto precedente circa i rapporti con l’UE. (2) La responsabilità della Regione sul diritto allo studio universitario deve essere ripensata per poter superare questa distanza e per far sì che il riconoscimento e la tutela del diritto costituzionale di accesso al sapere e di esercizio delle professioni intellettuali non sia un fatto meramente individuale. La cura di questo diritto interessa tutti, perché il suo esercizio porta alla Toscana un di più di capacità e di intelligenza delle cose. Questo richiede uno stretto coordinamento politico fra Regione, amministrazioni locali e rete delle università e della ricerca in Toscana, che venga formalizzato anche sul piano istituzionale attraverso una conferenza permanente dell’università, della ricerca e dell’innovazione. Tale coordinamento deve preservare la libertà di insegnamento e di ricerca e al tempo stesso aumentare le opportunità di accesso allo studio e alla ricerca dei singoli studenti ma anche delle comunità, delle realtà sociali ed economiche, perché dal bisogno di alcuni possono trarre vantaggio tutti. Questo coordinamento necessita di essere accompagnato da un significativo aumento dell’impegno finanziario di Regione e amministrazioni locali sul tema del diritto allo studio e della promozione della ricerca e dell’innovazione attraverso la rete dei centri universitari e di ricerca esistenti. Tale impegno deve essere strutturato nel tempo, in modo da creare un adeguata base di forza per lo sviluppo di aree strategiche per il futuro della Regione e per la sua piena integrazione nei grandi processi storici europei e planetari del nostro tempo.