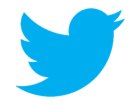Vorrei cogliere l’occasione dell’intervento, su queste pagine, di Michele Nicoletti (“Il paradosso del PD”, 17 febbraio), per dare un contributo alla discussione che si sta sviluppando sul ruolo dei cattolici democratici, specie dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie. Partendo da una premessa: chi scrive non è una voce “interna” alla cultura cattolica, ma si riconosce nella tradizione e nella storia della sinistra italiana, e in particolare appartiene a quella generazione che entrò nel Pci del “compromesso storico”, negli anni del carteggio tra Berlinguer e Mons. Bettazzi. Da questa sorta di imprinting giovanile nasce la mia attenzione al tema, oltre che dagli interessi di ricerca nel campo della teoria e della scienza politica.
Già nel dicembre scorso, quando si era da poco avviato “il percorso costituente del nuovo PD” (questa la formula usata negli stessi atti ufficiali del partito, dopo la sconfitta elettorale del 25 settembre), la questione è stata oggetto di notevoli polemiche, a partire dal convegno tenutosi il 19 dicembre e organizzato dall’Associazione degli ex-Popolari guidata da Pierluigi Castagnetti. Di fronte ai primi passi del dibattito sul nuovo Manifesto dei Valori, alcuni dei partecipanti al convegno lanciavano un grido di allarme: le posizioni che emergevano avrebbero stravolto l’impianto originario del Pd e reso sempre più difficile la presenza dei “cattolici” nel partito. Diciamo che, a posteriori, avevano ragione quanti, nel corso di quel convegno e successivamente, hanno contestato la legittimità stessa di un nuovo testo affidato ad un comitato nominato dall’alto, mai discusso veramente nel partito, e che poi doveva essere approvato dalla vecchia Assemblea Nazionale, quella destinata ad essere sostituita da quella eletta dal congresso. Questa obiezione procedurale ha avuto la meglio; e tuttavia, mettendo un po’ la polvere sotto il tappeto, si è arrivati ad una soluzione piuttosto singolare: è stata approvato (all’unanimità! brutto segno...) il nuovo testo (obiettivamente molto diverso da quello del 2008), ma senza chiarire il suo rapporto con il testo precedente: quest’ultimo rimane, ovviamente, come un documento storico fondativo del partito, ma è “ancora valido”, e in che senso, insieme al nuovo? Insomma, una vicenda, quella del doppio Manifesto, che appare come la rappresentazione plastica di un dilemma identitario tuttora irrisolto.
Nel corso del dibattito congressuale e, successivamente, con l’elezione di Schlein, la questione è riemersa e può essere formulata anche in modo molto semplice: un Pd decisamente “spostato a sinistra” è davvero un luogo inospitale per i cattolici? A me pare francamente che, messa in questo modo, la questione sia davvero mal posta. Assumendo che l’”unità politica dei cattolici” è oramai solo un ricordo del passato, e constatando come anche il voto dei cattolici (che si autodefiniscano tali, o che siano identificati sulla base della loro pratica religiosa più o meno intensa) sia oggi distribuito lungo l’intero arco delle posizioni politiche (anche quelle clerico-fasciste, purtroppo), appare allora conseguente concludere che anche i cattolici democratici hanno, e possono ben avere, collocazioni diverse nell’ambito di uno schieramento democratico, di sinistra, centrosinistra o progressista che dir si voglia. Non si comprende davvero se abbia ancora un senso parlare dei “cattolici democratici”, in quanto tali, come una componente omogenea, che nel nuovo Pd, si dice, rischierebbe di non avere più spazio e visibilità. Ma ci domandiamo: i “cattolici democratici” sono essenzialmente (solo) “moderati” o “centristi”; e quindi dovrebbero abbarbicarsi all’idea originaria di un Pd di “centrosinistra” (al cui interno sia poi loro affidato il compito di presidiare il “centro”)? A me pare un modo molto sommario, astratto e politicistico, di presentare la questione. Molto semplicemente, ci possono essere varie figure di “cattolici democratici”, tutte in egual misura pienamente interessate a svolgere un ruolo dentro un grande partito democratico: ci possono essere – faccio solo alcuni possibili esempi – cattolici democratici che si ispirano alla tradizione moderata e interclassista della Dc; o cattolici liberal; o cattolici “liberali” dal punto di vista della cultura istituzionale e liberisti in economia; o cattolici apertamente “di sinistra”, che si ispirano ad una tradizione cristiano-sociale più o meno radicale, con tante altre possibili sfumature.
Ciò che solleva molte perplessità è che, solo ora, e proprio ora, quando il corpo elettorale delle primarie ha scelto la via di un forte rinnovamento, ci si accorga del problema del “ruolo dei cattolici”: ma perché, davvero, negli anni alle nostre spalle, la cultura politica dei cattolici democratici è stata ben visibile e valorizzata nella vita del PD e solo ora rischia di essere oscurata? Non ci pare proprio, anche perché in realtà tutte le culture politiche fondatrici (non solo quella cattolica) hanno vissuto in una condizione di sostanziale e crescente marginalità: abbiamo assistito al progressivo immiserimento, fino all’irrilevanza, di una qualche elaborazione di cultura politica che avrebbe dovuto sorreggere e ispirare il modo di essere e di operare del Pd. Una tara costitutiva, secondo la mia opinione, legata all’idea originaria di un partito post-ideologico, che (si presumeva allora) doveva e poteva “tenersi insieme” sulla base dei programmi e delle “cose da fare”, non sulla base di una qualche identità politico-culturale o di un patrimonio condiviso di idee. Quelle tradizioni di cultura politica che pure avrebbero dovuto ispirare il nuovo partito, facendone il luogo in cui potessero al meglio incontrarsi e fecondarsi reciprocamente, sono divenute sempre più ininfluenti nel concreto suo modo di essere e di operare. E ciò è accaduto perché la “costituzione formale” e quella “materiale” che hanno contrassegnato il PD non hanno certo valorizzato questa dimensione: ci si è occupato di tutt’altro, per così dire.
Ma quale avrebbe potuto essere questa visione condivisa? E’ qui il nodo cruciale, tuttora irrisolto e a cui oggi il Pd dovrebbe finalmente dedicarsi: come ha ben scritto Michele Nicoletti, bisogna adoperarsi “perché si apra, con determinazione, una riflessione sull’idea di democrazia che il PD intende fare propria e praticare”. L’identità “democratica” poteva essere (e non è stata), e potrebbe essere tuttora, un’identità condivisa, che accomuna culture e tradizioni diverse. Ma a patto che la si assuma in un senso “forte” e complesso: ossia, come un orizzonte ideale e come un paradigma critico con cui costruire l’azione politica nel nostro tempo. Una visione dinamica, non pacificata né neutralizzata, della democrazia, aggiungo, come progetto costantemente proteso ad una più compiuta (e mai definitiva) realizzazione dei suoi stessi presupposti normativi. Presupposti che aprono sempre una frontiera conflittuale: in particolare, oggi, contro gli “imperativi sistemici” e le logiche impersonali, contro quel primato dell’economia e della tecnocrazia sulla politica democratica, che caratterizza il capitalismo contemporaneo. “Imperativi”, vincoli e e logiche che schiacciano la vita degli individui e delle comunità, e che ne limitano fortemente le loro potenzialità di realizzazione umana.
Ma perché questo accada, perché questa cultura democratica possa diventare veramente il tratto identitario del Pd, vi è un requisito da soddisfare, come ho cercato di mostrare nei miei recenti lavori: è l’intero modello di partito del Pd a dover essere radicalmente modificato. La chiave di questa riforma sta nel ripensare integralmente il circuito tra discussione-partecipazione-decisione: sta nel curare la malattia mortale che sta (è ancora presto per dire “stava”) attanagliando il Pd, stretto tra il plebiscitarismo dell’investitura diretta del leader e la spartizione feudale e oligarchica del partito periferico. E sta nella creazione di un modello di partito che smantelli le ragioni strutturali e intrinseche che alimentano l’attuale tipo di correntismo, fatto di posizionamenti e di aggregazioni mutevoli, di conflitti di potere per il controllo degli organismi locali (il tutto poi finalizzato alla conquista delle candidature nelle istituzioni), in assenza di sedi e di strumenti per una elaborazione collettiva di idee e visioni, programmi e politiche. Come ricorda efficacemente Nicoletti, quella vigente fin qui nel Pd è stata “una democrazia di competizione tra élite, la cui selezione è però del tutto legata all’abilità di sopravvivere all’interno di questo meccanismo piuttosto che alla loro effettiva capacità di rappresentare settori della società”. E’ da questa condizione che bisogna uscire.
Non occorre qui entrare nei dettagli di una possibile riforma: si potrebbero discutere e indicare anche le modifiche puntuali da introdurre nello stesso Statuto. Ma l’essenziale è puntare su un partito che sappia vivere produttivamente il proprio pluralismo interno, che valorizzi tutte le sue diverse cultura politiche, che le renda visibili e le faccia veramente confrontare tra loro. La via è quella di un modello di democrazia interna che sia insieme rappresentativa, partecipativa e deliberativa: ossia, da un lato, si fondi su organismi collegiali di direzione politica i cui membri siano dotati di una propria autonoma legittimità (cosa che oggi non accade perché, com’è noto, i componenti dell’Assemblea Nazionale e poi della Direzione sono eletti con le liste bloccate collegate ai candidati-segretario, e quindi “nominati” dall’alto); e, dall’altro lato, che produca le decisioni sulla “linea” e gli orientamenti del partito attraverso forme, luoghi e canali, di interazione dialogica e pratiche collegiali di confronto: fasi in cui si costruisce la legittimazione discorsiva (per usare un concetto di Habermas) di una decisione, affidandone poi la definizione conclusiva al lavoro di sintesi svolto dal segretario e alle deliberazioni degli organismi.
Ritengo questo passaggio cruciale: questo partito può essere “tenuto insieme” solo se si costruiscono processi decisionali inclusivi, che valorizzino quanto più possibile idee e culture politiche diverse, esperienze e competenze, presenti nel partito e soprattutto intorno al partito. Ma la “sintesi” non può essere una mediazione “statica”, una mera giustapposizione di tesi, che alla fine costringano o all’ubbidienza passiva o alla rottura, o che si traducano in una totale afasia o in una cacofonia paralizzante. Riprendendo una nota formula di John Rawls, non è sufficiente un mero modus vivendi, una coesistenza reciprocamente indifferente di visioni che non dialogano tra loro, ma un “consenso per intersezione”, o per “sovrapposizione” (overlapping consensus), come lo definisce Rawls: costruire cioè un’area comune a partire da concezioni del mondo diverse e tuttavia non lasciando queste visioni racchiuse nella dimensione privata di ciascuno, ma facendole pienamente valere anche nel dibattito pubblico, come argomenti che possano risultare convincenti anche agli occhi di chi muove da altri presupposti di valore o da altri principi.
Nella vita di un partito democratico che prenda sul serio il proprio pluralismo interno, entro la cornice comune della democrazia assunta come orizzonte ideale e paradigma critico-conflittuale, questo modello rawlsiano può trovare un’esemplare applicazione. In primo luogo, definendo regole e procedure che consentano una discussione quanto più larga e inclusiva, concentrata nel tempo ma profonda e diffusa. Possiamo rimanere “in minoranza” e nondimeno giudicare legittima una decisione collettiva, solo se alla sua definizione possiamo dire di aver concorso, direttamente o indirettamente, contribuendo alla sua costruzione.
Si apre ora una fase molto delicata, e una grave responsabilità grava sulle spalle della nuova segretaria. Per quel che si può comprendere, non sarà una leadership solitaria: anzi, si può notare e apprezzare un atteggiamento aperto e di ascolto. Ma occorre superare le inerzie e le resistenze di tutti coloro a cui, in fondo, non dispiace un partito feudalizzato, che conceda un po’ a tutti una qualche porzione di potere e di visibilità: ma sarebbe la fine per il PD, si tratterebbe di una concezione nefasta del “pluralismo”, fondata sul fatto che tutti dovrebbero avere un posto (o un posticino) al sole; ma così, è chiaro, non si andrebbe molto lontano. Tutti coloro che vogliono ridare voce e respiro alle culture politiche (al plurale) del pensiero democratico, non possono che battersi con forza per una riforma del modello di partito, per far sì che esso, in primo luogo, torni ad essere un luogo di intelligenza e saggezza collettiva. Il “ruolo” dei cattolici (siano essi moderati e centristi o, di contro, radicali e di sinistra), ma allo stesso modo lo spazio di chi vuole inscriversi in una rinnovata tradizione del pensiero socialista (si pensi solo al contributo di un pensatore dell’ultima generazione della Scuola di Francoforte, Axel Honneth); o ancora lo spazio di chi vuole ispirarsi ad un liberalismo di sinistra, o di chi vuole dare rilievo alla nuova centralità della questione ambientale: ecco, tutte queste, ed altre culture politiche democratiche, possono avere un destino comune, dentro un grande partito, solo se questo partito assume fino in fondo la “democrazia” non solo come “metodo” di fronte alle istituzioni (e ci mancherebbe, si potrebbe dire!), ma anche come “pratica” del suo stesso modo di essere e di operare. Ed è sul modo concreto con cui si può ottenere questo obbiettivo, che la discussione ora dovrebbe concentrarsi.