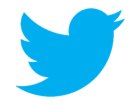La vitalità delle organizzazioni sociali si rafforza se può contare su solidi marcatori originari che le identificano, rafforzano la tenuta associativa e danno senso e misura alle azioni quotidiane. Lo slancio innovativo dei fondatori costituisce un patrimonio che a ogni ricorrenza merita di essere verificato da una solida riflessione su di sé. Così è per la Cisl a settant’anni da quel 30 aprile 1950 in cui i rappresentanti delle forze sindacali democratiche hanno proclamato i medesimi ideali di libertà, di
solidarietà e di giustizia sociale affermati dai padri della Repubblica. Di differente estrazione politica, pur nella scelta aconfessionale, si sono riconosciuti nella «decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana», esplicita evocazione della Dottrina sociale.
Questa presa in carico integrale della persona lavoratore si poneva in alternativa alla prevalente vocazione ideologica del sindacato italiano alla conflittualità sociale. L’affermata centralità della persona definiva come orizzonte il pieno riconoscimento della cittadinanza e dell’emancipazione dei lavoratori e delle loro famiglie in una società libera, aperta, dinamica. Piena democrazia, dunque, ma anche accettazione delle regole di un’economia di mercato che, per quanto iniqua, poteva essere indirizzata allo sviluppo per opera di un assetto economico (l’“economia mista") che si reggeva sulla condivisione di responsabilità tra le imprese private, le forze sociali e un attore pubblico consapevole che la buona politica orienta gli interessi frazionali, senza invadenze, verso obiettivi generali e il bene comune.
La potenza del disegno originario era la premessa indispensabile ma non esauriva la marcatura identitaria della Cisl delle origini così come è giunta sino a noi. Un segno riconoscibile era l’innovativa proposta di articolare la contrattazione sino a livello d’impresa per porre in relazione gli incrementi salariali all’andamento della produttività aziendale. Nei territori e in sede centrale si contava sulle potenzialità multiformi della regolazione sociale. Diversi livelli d’azione per costruire spazi di partecipazione e portare così la sfida nel cuore dei rapporti costitutivi del capitalismo industriale, tra capitale e lavoro.
Un progetto non anacronistico perché si fondava sulla consapevolezza che, nel nostro paese, l’incompiuta modernizzazione dei rapporti di lavoro doveva confrontarsi con il rapido avanzare dell’innovazione tecnologica e della riorganizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese. Questa era la sfida. Ricusata la via semplicistica della contrapposizione ideologica tra capitale e lavoro, non restava che posizionarsi sul terreno dell’economia di mercato avvalendosi degli ambiti di autonomia delle democrazie occidentali senza trascurare la prospettiva dell’unificazione europea.
Questa impostazione si fondava su un atteggiamento di responsabilità nei confronti dell’intera comunità nazionale e internazionale. Non dunque una mera rivendicazione di diritti o una restaurazione di logiche assistenzialistiche, ma la sollecitazione ad affrontare le emergenze del Paese: la qualificazione del mercato del lavoro a partire dalla preparazione scolastica; una mobilitazione dal basso delle società locali per non affidare il Mezzogiorno al solo trasferimento di risorse pubbliche; la modernizzazione della pubblica amministrazione; un welfare della persona in grado di segnare la traccia dello Stato sociale. Orientamenti credibili se, in prima istanza, le stesse organizzazioni sindacali dimostravano di essere in grado, tramite politiche formative innovative e con l’aiuto del mondo degli studi e della ricerca, di promuovere tempestivamente la maturazione politica, sociale e tecnica della propria classe dirigente e degli operatori di prima linea. Così da rompere la frontiera su cui erano aggressivamente attestati, anche nel mondo del lavoro, la diseducazione democratica e sociale e il sistema di
privilegi su cui aveva fatto aggio il regime fascista.
Si prospettavano, consapevolmente e senza timore, anni difficili, di isolamento, di faticose conquiste nel breve periodo per affermare quel “risorgimento sindacale" che, secondo Mario Romani (il professore della Cattolica che collaborava con Giulio Pastore), sfidava il sindacato ad affermare la centralità della persona del lavoratore. Chi ancor oggi dissentirebbe da tale affermazione? Ma sotto le percosse che Coviti-19 sta infliggendo alle persone, nel dolore dei lutti e nella dispersione del lavoro, i proclami e le formule retoriche non reggono. Nel 1950 l’elemento ordinatore della convivenza era il mercato. Col tempo l’ordine economico liberale ha assunto la sostanza di un’egemonia neoliberista segnata in una lunga stagione avversa alle rappresentanze del lavoro. Nella società globale il mercato ha ceduto terreno alla speculazione.
Oggi, l’indiscutibile emergenza che spinge ad affidarsi totalmente all’azione pubblica - non per riconosciuta autorevolezza ma in quanto erogatrice di denaro facile - profila un nuovo rito sacrificale della libertà associativa e del ruolo dei soggetti intermedi. Altra era l’istanza affermata nel 1950: non il mercato ma il lavoro degno e la socialità possono animare l’ordine umano delle nostre polis e dello stesso mercato. Per non ridursi a mera rivendicazione, il “nuovo risorgimento" può contare sulla coscienza interiore del sindacalismo democratico testimone, per esperienza diretta, della possibile stretta coerenza tra affermazioni di valore e vita organizzativa, tra contrattazione e partecipazione sperimentando nuove forme e nuovi spazi di rappresentanza. Si tratta “solo” di operare da sindacato, più che in passato, ovunque le tutele sociali possano andare a sollievo di chi del lavoro, o dell’impegno sociale, ha necessità per bisogno materiale e di senso. Risorgere è rigenerare inclusive comunità intergenerazionali del lavoro.