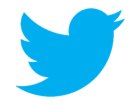Il settore agricolo italiano, oggi meglio denominato sistema agroalimentare e forestale, è un ambito economico di dimensioni ridotte che rappresenta circa il 4% del valore realizzato dall’intero sistema economico nazionale (Annuario dell’agricoltura 2014), valore composto per il 2,2% da quello del settore agricolo in senso stretto e per l’1,8% dall’industria alimentare.
Tuttavia, se esso viene inserito in un contesto più ampio che tenga insieme l’intera catena del cibo cioè anche il settore terziario con la distribuzione e la commercializzazione delle materie prime e dei prodotti trasformati nonché con i tanto rinomati servizi di ristorazione italiani, l’intero sistema muove poco più di 274 miliardi di euro e rappresenta il 17% del PIL.
Nonostante il cibo sia un motivo di continuo possibile contatto con l’ambito agricolo, il settore ha attraversato gli ultimi decenni del ‘900 in una sorta di isolamento. E’ stato sentito “lontano e diverso” dalla maggioranza della popolazione e, soprattutto, è stato vissuto come tale dagli stessi suoi addetti sia gli imprenditori agricoli che i lavoratori che a vario titolo svolgono attività di supporto o servizio al settore. Sono stati gli anni in cui i molti nipoti e forse anche bis nipoti di molti agricoltori hanno interrotto di fatto ogni rapporto e relazione con le proprie radici rurali.
Una delle novità del nuovo millennio riguarda proprio un rinnovato interesse ai temi dell’agricoltura che può essere fatto derivare sia dalla aumentata sensibilità verso i temi della salubrità degli alimenti e dell’ambiente sia dall’esigenza di una certa parte della popolazione di tornare a lavorare dentro i ritmi della natura e/o a maggior contatto con essa. E’ interessante notare come nel settore agricolo il 2014 ha segnato un incremento dell’occupazione del 1,6 % dopo tanti anni di segno negativo e che la quota di occupati fra i 15 e 34 anni sia cresciuta del 4,6%.
La produzione agricola in senso stretto nel nostro Paese è costituita soprattutto dalle coltivazioni vegetali che sono circa il 50% del valore complessivo seguite dalle produzioni animali (32%) e dalle cosiddette attività di supporto e secondarie che corrispondono al 18% del valore della produzione. La crescita costante di queste ultime negli anni è un dato degno di nota perché riguardano alcuni sviluppi recenti del settore: l’agriturismo praticato da circa 21.700 aziende, la produzione di energia che ha generato un valore stimato in circa 1,5 miliardi di euro - pari al 2,8% del totale valore della produzione agricola -, le fattorie didattiche che contano circa 2.500 aziende e la cosiddetta “agricoltura sociale” che ha avuto un importante riconoscimento con la legge 141/2015.
Il settore si sta di fatto riaprendo all’intero sistema economico e sociale e sta provando ad offrire i propri prodotti in chiave di sostenibilità, salubrità e qualità, ma anche cercando di reinventarsi funzioni inedite quali quelle del custode dell’ambiente (manutenzione dell’arredo urbano o dei territori a rischio idrogeologico), dell’offerta di servizi sociali (handicap fisico e mentale, infanzia ecc.).
Fa parte di questo fenomeno anche il nuovo rapporto che si sta instaurando fra città e campagna. Di solito concepiti come due ambiti in antitesi, se non addirittura in competizione sull’uso delle risorse. In allegato si propone la presentazione di uno studio del CREA sulle relazioni fra agricoltura e città illustrata al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in occasione della presentazione dell’Annuario dell’agricoltura italiana 2015. E’ interessante notare che l’agricoltura periurbana non sia residuale come si è soliti pensare, ma ben orientata al mercato e che nei sette maggiori poli urbani italiani (Torino, Genova, Milano, Monza e Brianza, Roma, Napoli e Palermo) ci siano ben 6.000 aziende agricole. L’agricoltura urbana, invece, come era logico aspettarsi, si colloca al centro di funzioni complesse, da quella didattica a quella terapeutica, da quella ludico-ricreativa a quella della gestione delle risorse naturali locali, ecc.. La funzione economica è comunque presente anche se in misura ridotta.
Una sfida all’agricoltura di oggi: produrre di più con meno
Come tutti i settori economici anche l’agroalimentare è cresciuto e radicalmente cambiato a causa del progresso tecnico.
Sin dal dopo guerra iniezioni intense di innovazione sono state la risposta al necessario incremento della produttività dell’agricoltura per sfamare una popolazione in rapida crescita e alla riduzione dei costi attraverso l’incremento dell’efficienza d’uso dei fattori produttivi (terra, capitale, lavoro).
Negli anni 2000 l’agroalimentare si è trovato a fare i conti con una crescente sensibilità verso l’impatto ambientale delle attività produttive e l’interesse sempre più consapevole del consumatore alla salubrità del cibo. In realtà i concimi, gli antiparassitari, i diserbanti avevano già cominciato a cambiare caratteristiche e effetti con la fine del secolo e i risvolti dell’uso improprio dei terreni e delle risorse idriche avevano già indirizzato i processi produttivi agricoli verso una migliore razionalità e una riduzione della forzatura dei processi. Tuttavia nel nuovo secolo, l’attenzione al cambiamento climatico e alla biodiversità da un lato e alla necessità di sfamare una popolazione crescente dall’altro ha portato la società civile e i governi dei Paesi del mondo sviluppato a chiedere all’agricoltura di produrre di più, ma con minore utilizzo e consumo di risorse. Una sfida nuova per paradigmi produttivi e scientifici che hanno basato la crescita produttiva su l’incremento costante degli apporti di risorse.
L’articolo del Magazine della Rete rurale nazionale che si propone di seguito cerca di approfondire il tema dell’innovazione nell’agroalimentare interrogandosi sulla complessità delle problematiche e sottolineando che “l’innovazione si distingue dalla creazione e forse anche dall’invenzione perché si sviluppa all’interno di una relazione (Cerroni A. 2013); infatti mentre una creazione nasce di norma dall’inventiva e dalle capacità di un singolo, l’innovazione, a causa della sua natura applicativa e volta alla soluzione di un’esigenza, necessita del coinvolgimento di più soggetti.”
Sarebbe quindi indispensabile, se si vuole indirizzare il sistema agroalimentare verso nuovi paradigmi innovativi, coinvolgere tutti gli attori: le imprese e i loro clienti, i cittadini che vivono in un certo territorio rurale e gli stakeholders che attuano le nuove politiche di sviluppo, in modo che il processo di novità da innescare venga condiviso e tenga conto di tutte le esigenze: il reddito delle imprese, la qualità dei prodotti, la salvaguardia ambientale dei territori, lo sviluppo economico dei sistemi. E’ un processo complesso che va governato e direzionato utilizzando gli strumenti che le politiche europee forniscono avendo un chiaro progetto di crescita.
Un altro aspetto che l’articolo sottolinea riguarda l’importanza di conoscere e capire le problematiche del target del processo di innovazione, gli imprenditori, e, soprattutto, la necessità di utilizzare le risorse finanziarie delle politiche europee, nazionali e regionali per lo sviluppo reale di fasce di aziende che non riescono autonomamente a fare il salto di qualità e non a beneficio di imprese già avanzate e in grado di muoversi con le proprie gambe.
E’ quindi necessario sottolineare come “il processo di adozione di un’innovazione sia complesso, strettamente connesso con le caratteristiche del capitale umano aziendale, relazionale e territoriale e quindi possa essere considerato a tutti gli effetti anche un processo di apprendimento.”
Se non si attrezza il sistema con strumenti in grado di accompagnare le imprese in difficoltà e di sostenerle negli investimenti necessari si promuoverà uno sviluppo ineguale e si approfondiranno le già marcate differenze.