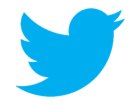Il forte disorientamento che stiamo vivendo intorno alla vicenda della guerra è legato all’impatto dei conflitti più caldi (Ucraina e Israele/Palestina) ma anche di tutte alle altre decine di conflitti armati che lacerano il Medio Oriente (si pensi alla Siria, all’Armenia, ai curdi), all’Africa (Congo, Sudan) oltre alle ancor più numerose situazioni di forte tensione e di repressione dei diritti civili fondamentali che schiacciano in particolare donne e bambini (si pensi all’Afghanistan, ma anche a Libia, Tunisia).
GEOPOLITICA, DIRITTO E TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA
L’ingresso dirompente della politica estera USA, con Trump, ha ribaltato il metodo delle relazioni multilaterali e messo in discussione i principi del diritto internazionale. La logica della forza e la politica di potenza possono forse portare a qualche tregua (peraltro benvenuta) ma difficilmente porranno le basi per una pace duratura e di riconciliazione tra popoli che si sono duramente e tragicamente combattuti. La politica di potenza può apparire funzionale in termini di rapidità, ma è ben lungi dal costruire rapporti pacifici e cooperativi; serve piuttosto a ridefinire il potere tra i “giganti” (che tendono ad operare fuori e contro ad ogni logica democratica) emarginando i più piccoli e meno ricchi. Il successo di queste logiche (sia nei rapporti internazionali che in quelli interni) non dovrebbe però farci smarrire il valore dei principi di dignità e di collaborazione tra popoli e stati, secondo regole comuni che garantiscano il rispetto dei più deboli. Proprio quando appare più fragile, si sente in modo evidente la necessità del diritto internazionale e l’importanza di organismi internazionali che siano in grado di promuoverlo, operando secondo il metodo del dialogo. L’alternativa sappiamo bene qual è: il dominio imperiale senza alcun freno, con accordi unilaterali basati sul ricatto della forza militare, economica, tecnologica, che ricordano una forma di “conquista”.
Oltre ai cambiamenti geo-politici, che si intrecciano con la crisi delle democrazie occidentali, un secondo aspetto va tenuto in grande considerazione: si tratta del cambiamento tecnologico che influisce potentemente anche sui conflitti: a cominciare dalla rivoluzione digitale, dalla robotica, dall’intelligenza artificiale, dall’uso massiccio dei satelliti. Novità che toccano non solo i sistemi d’arma e il modo di combattere, ma più a fondo coinvolgono il sistema di ricerca e produzione, di comunicazione ed alleanze strategiche, di organizzazione e controllo sociale.
IL VALORE DELL’EUROPA E IL NODO DEL RIARMO
Si pone quindi nuovamente in modo drammatico il nodo della possibilità di rispondere all’aggressione (variamente armata) ed il ruolo dell’Europa (e in essa dell’Unione Europea). Proprio in questa fase non possiamo smarrire l’ideale di un continente in pace, che rinuncia alla guerra e all’uso della violenza armata per risolvere controversie e conflitti politici. Né possiamo trascurare il rapporto tra democrazia e pace, che ha consentito quel lungo processo di costruzione dell’integrazione politica, economica e sociale dell’Europa. Oggi la tentazione è quella di liquidare con superficialità il cammino percorso, abbandonando con leggerezza le conquiste sociali, economiche e culturali (e nelle nostre tiepide case si vocifera di come “l’Europa non ha mai fatto nulla … è una costruzione impossibile … meglio tornare ai singoli stati nazionali”). Una tentazione incentivata da molti attori della comunicazione, che in nome di un preteso “realismo” affermano che la guerra è inevitabile e che il diritto internazionale è un’illusione per poveri ingenui. Mentre ben conosciamo l’enorme quantità di interessi particolari che le guerre premiano a danno dei popoli, delle famiglie, delle persone.
Ma proprio perché non siamo una banda di poveri sciocchi, è opportuno prendere sul serio i rischi di allargamento dei conflitti. Il tema della difesa europea si ripropone dopo anni in cui - “sotto l’ombrello” della NATO a guida statunitense – esso è rimasto ai margini, nonostante i diversi interventi del presidente Mattarella. Ora, in una fase in cui gli USA di Trump considerano l’UE come un avversario (“costruito per fotterci”!), si riaccende il contrasto sulla posizione da assumere circa il riarmo indotto dalla crisi ucraina e dal progettato disimpegno degli USA dalla difesa europea.
In sostanza, anche in questo caso il tema andrebbe trattato con serietà e ragione, perché la complessità è evidente e la semplice contrapposizione tra “bellicisti” e “pacifisti” non aiuta, ancor più considerando la varietà di motivazioni e le “narrazioni” presenti nei due schieramenti.
IL RIPUDIO DELLA GUERRA E LA DIFESA COMUNE
Vale in ogni caso riprendere il riferimento principale che viene dall’art. 11 della nostra Costituzione, in cui si afferma che “'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”. Ripudiare la guerra non significa ripudiare la difesa (anche armata) in caso di aggressione. Non a caso, con l’avvio dell’Italia democratica, si modificò il nome “Ministero della Guerra” in “Ministero della Difesa”. Anche nel dibattito tra i Costituenti si affacciò la proposta di una smilitarizzazione completa, ma poi si scelse di mantenere l’esercito, per la difesa, appunto. Già negli anni ’50 si cominciò a parlare di un sistema di difesa europeo (che implica una “cessione di sovranità”, come prevede tutto il sistema giuridico europeo). Ma le visioni nazionalistiche ostacolarono il progetto. Ora il progetto ridiventa di forte attualità e ciò sembra implicare un poderoso investimento per il riarmo (con il passaggio delle spese militari dal 2% al 4-5%). Non basta però destinare risorse (peraltro ancor da ben individuare), il nodo è come organizzarle e con quali obiettivi. Investire nella difesa significa semplicemente comprare o fabbricare armi? L’efficacia della deterrenza passa solo attraverso il numero di missili e carri armati? Una difesa comune permetterebbe di risparmiare risorse, che altrimenti sarebbero sottratte ad altri essenziali servizi pubblici (dalla sanità all’istruzione, dalla difesa del territorio alla trasformazione ecologica, dall’inclusione dei migranti allo sviluppo dei servizi sociali per popolazioni sempre più anziane).
SOVRANISMO E POLITICA ESTERA COMUNE
Il piano proposto dalla Presidente della Commissione UE (Rearm Europe) solleva però non pochi dubbi, circa l’intento di andare in questa direzione, anzitutto perché lascia piena facoltà di azione ai singoli stati (rivelando forse la subalternità ad una mentalità nazionalistica di molti stati membri), a fronte della necessità di porre chiari obiettivi e criteri per una politica estera comune. Essa potrebbe mettere in campo molti strumenti, volti a evitare la guerra, più “pesanti” proprio perché espressione di una realtà ben più vasta e rilevante che non i singoli stati: dalle relazioni diplomatiche agli accordi di collaborazione e cooperazione, agli investimenti nell’economia civile e nella tutela sociale delle popolazioni, con processi di disarmo reciproco controllato (a cominciare dalle armi nucleari). Una politica estera comune sarebbe in grado di sviluppare nella percezione dei cittadini quel senso di essere e sentirsi “cittadini europei”, indispensabile per invertire la rotta rispetto all’apparente e illusoria sicurezza offerta dal sovranismo e dalla chiusura nazionalistica. Molto chiaro il giudizio espresso dal card. Zuppi al Consiglio CEI del 10 marzo 2025: “Troppo si è disprezzato il dialogo tra governi, mentre le sedi internazionali sono state svuotate di significato e prestigio, a partire dall’Onu. Il linguaggio internazionale è divenuto molto duro e aggressivo e mira a colpire e screditare più che a creare le basi del dialogo …. [Bisogna rifiutare] i messaggi di violenza, le immagini di guerra, l’esaltazione della forza e del vincente, il disprezzo per il debole ha effetti deleteri sulla mentalità e sui comportamenti. I giovani sono recettori indifesi di questo modo di vivere e di pensare. Formare cristiani responsabili non è compito confessionale, ma è dovere della Chiesa ed è un servizio al mondo».
Senza una visione dell’Europa, senza una politica estera comune e senza una difesa comune, anche la deterrenza fornita dall’aumento degli armamenti finisce per rimanere frammentata e poco efficace. Il riarmo infatti è un gioco molto pericoloso: è facile intenderlo come sintomo della volontà di considerare la guerra uno strumento possibile di soluzione. Certo non si può trascurare il nodo della deterrenza, avendo a che fare con interlocutori che paiono intendere le relazioni internazionali come una continua prova di forza. D’altro lato sarebbe ingenuo non cogliere il rilievo economico del processo di riarmo, che da strumento può divenire un fine, con una torta di miliardi da spartirsi tra alcune nazioni e cartelli di imprese. Ed è anche necessario considerare come questa scelta implichi una ricaduta culturale – basata sulla logica della forza (magari condita con un po’ di razzismo) – che impronta le relazioni non solo tra gli stati ma anche tra gruppi, classi e persone. La lezione che ci viene dalla storia europea nella prima metà del Novecento è molto chiara (e terribile): l’autodistruzione materiale e morale di un continente venne proprio da quelle logiche.