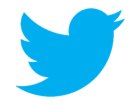Chiunque abbia mai provato a camminare in alcuni quartieri di periferia di grandi città sa benissimo che la sicurezza è un bene primario. Ai margini delle nostre società, dove lo stato spesso fallisce uno dei suoi compiti primari – che Max Weber chiamava il monopolio, cioè il controllo, della violenza – è facile sentirsi abbandonati. In questa terra di nessuno, la rabbia cresce. Rabbia verso chi, vivendo nei quartieri 'sicuri', dove la polizia – privata quando non c’è quella pubblica – garantisce una presenza costante, parla di ospitalità. E rabbia nei confronti dell’'altro più altro' (lo straniero) che abita nello stesso palazzo, a cui si addebita la propria sofferenza. Non sto facendo una apologia del rancore che attraversa le nostre società. Solo cercando di fissare un punto di partenza per andare al di là delle solite sterili contrapposizioni. La sicurezza, insisto, è un bene primario. Uno dei fondamenti della sovranità politica, che è poi il presupposto della democrazia. Al tempo stesso, anche la sicurezza ha le sue patologie: l’idea di mettersi al sicuro dal rischio dell’altro, al di là di ogni ragionevole limite, rende paranoici. Se ci pensiamo bene, il rapporto con l’altro ha sempre, per definizione, un margine di rischio col quale dobbiamo convivere: è su questo punto di fuga che si giocano, in fondo, la nostra libertà e la nostra responsabilità. Il modo in cui lo stato moderno ha cercato di sciogliere questo nodo originario della vita insieme è quello di cercare un punto di equilibrio tra chiusura e apertura. Una certa chiusura è necessaria, pena l’evaporazione di qualsiasi comunità politica.
Ma chiudere non vuole dire sigillare. I confini devono essere porosi perché altrimenti diventano soffocanti (prima di tutto per quelli che stanno dentro). Lo strumento con cui confini porosi sono stati costruiti è quello della cittadinanza. La cittadinanza, strumento giuridico e cultuale insieme, definisce chi è il cittadino, i suoi diritti e doveri. Le regole di ingaggio in una comunità. Ora è evidente che nell’epoca in cui viviamo è questo il punto su cui occorre tornare per sfuggire all’assurda dialettica tra chiusura totale e apertura indiscriminata. L’interconnessione creata negli ultimi decenni avvicina gli abitanti del mondo. Quando dopo la finanza e le merci, hanno cominciato a muoversi le persone (e non più solo per turismo), ci siamo accorti che il mito della globalizzazione mistificava la realtà. Nella situazione in cui ci troviamo, pensare di tornare a tracciare linee di divisione perfettamente impermeabili comporta l’uso della violenza. Di molta violenza. Ma siamo sicuri che per questa via raggiungeremo l’agognata 'sicurezza'? Non è questo un abbaglio che rischia, al di là delle intenzioni, di rendere il mondo e le nostre vite ancora più insicure?
D’altra parte, occorre riconoscere alcune semplificazioni di questi anni. Al di là dell’emergenza – che il comune senso di umanità ci impone di rispettare – chi entra in un territorio deve dimostrare di avere la volontà di diventare cittadino di quella nuova comunità. È un principio fondamentale senza il quale finiamo per distruggere le nostre stesse comunità politiche. E la comunità ricevente deve sapere che cosa intende chiedere ai nuovi arrivati. Ciò comporta la gradualità del processo, che altrimenti diventa ingestibile. Cioè regole e verifiche. Anche includendo l’ipotesi di un’espulsione (vera) laddove si riconosca che non ci sono le condizioni per andare avanti. Il percorso per diventare cittadini deve essere accessibile ma serio. Ed eccoci al punto: se lo strumento – politico e giuridico – è quello della cittadinanza, perché non aprire la questione a livello europeo? Si dirà, è un obiettivo irrealistico. Ma abbiamo alternative? Nel passato sono stati firmati trattati per costruire una cosa difficilissima come la moneta unica, dopo anni in cui le monete sono state 'armonizzate'. E così, per arrivare a definire standard europei comuni per chi vuole entrare e diventare cittadino ci vorranno anni. Ma si tratta di fissare l’obiettivo e di cominciare un percorso comune. Se non vogliamo farci travolgere dagli eventi, non c’è altra scelta: può esistere una Europa sotto pressione migratoria dove il percorso per diventare cittadino non segue gli stessi criteri? Ancora oggi, la maggior parte degli europei non è contro i migranti. É contro una politica che, per meri interessi elettorali di breve termine, non sa imprimere una linea sensata.
Rinunciando al suo compito di garantire la sicurezza. In parallelo, vi è naturalmente la necessità di impostare una politica estera comune che intervenga in modo vigoroso sui Paesi di partenza e sugli snodi dei percorsi di transito. Perché la pressione rimane comune troppo alta da sostenere e va ridotta. Tutto ciò se vogliamo affrontare il tema ragionando e non sbraitando: cioè riconoscendo che il bene primario della sicurezza – a cui sono particolarmente sensibili i ceti più deboli – lo si raggiunge a condizione di riconoscere il senso del limite rispetto a sé e al mondo. E tenendo conto che il termine riguarda tutti, i ricchi e i poveri, i forti e i deboli. Mai come in questo momento ci rendiamo conto di essere in relazione gli uni con gli altri. E, come sempre nella storia, è il modo in cui tale relazione viene concretamente declinata a fare la differenza.