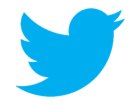Note sparse in tema di regionalismo differenziato, alla luce della recente giurisprudenza costituzionale
Premessa
È di pochi giorni fa la notizia che il popolo italiano non sarà chiamato a pronunciarsi, in sede di referendum, sulla legge in materia di regionalismo c.d. “differenziato”.
Ripercorriamo, seppure sinteticamente, quanto è accaduto.
La ricostruzione dei fatti
Alleggerita la morsa della pandemia, come si sa, si è tornato a discorrere di regionalismo “differenziato” e si è giunti all’emanazione della l. n. 86 del 26 giugno 2024, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”. Tale normativa è stata oggetto di richiesta di referendum abrogativo ma è stata altresì impugnata dinanzi alla Corte costituzionale da quattro Regioni (Puglia, Toscana, Sardegna e Campania).
Dalla bella sent. n. 192 del 2024, una sorta di “compendio” di Diritto regionale, la normativa in discorso è uscita “a pezzi”; in estrema sintesi, con la decisione da ultimo richiamata, alcune previsioni della l. n. 86 sono state dichiarate incostituzionali (attraverso interventi di accoglimento “secco”, additivi e sostitutivi), altre sono state reinterpretate (attraverso la tecnica delle interpretative di rigetto) e altre sono state fatte salve, essendo stato escluso il contrasto con la Carta.
D’altra parte, che le criticità fossero molte era stato fatto notare da un “coro” di voci che si erano fatte sentire all’interno della società (tra queste, la dottrina costituzionalistica ma anche la Chiesa e molti altri). Si potrebbe dire, “tanto tuonò che piovve”,
Due precisazioni si rendono particolarmente opportune, alla luce della sent. n. 192 del 2024.
Per prima cosa, la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sull’intero testo della legge; in altre parole, quest’ultima non contrasta in tutte le sue parti con la Carta.
Secondariamente, l’art. 116, III comma, Cost., sulla base del quale le Regioni a statuto ordinario (perché ad esse si riferisce il Titolo V della Costituzione) possono richiedere “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” nelle materie ivi indicate, non provoca una “rottura costituzionale”, ossia una contraddizione interna al dettato costituzionale. In poche parole, il c.d. regionalismo “differenziato” – almeno, in astratto – può realizzarsi, ma non nel modo (in gran parte) voluto dalla legge n. 86 del 2024.
Peraltro, la legge n. 86 non rientra tra quelle “costituzionalmente necessarie” ovvero l’art. 116, III comma, Cost., non richiede (appunto, obbligatoriamente) una normativa di attuazione; sulla base della sua formulazione, infatti, la previsione in parola poteva (e può) essere inverata nell’esperienza a prescindere da un intervento dal legislatore, che però aveva (ed ha) – ovviamente – la facoltà di legiferare in materia al fine di specificare maggiormente quanto disciplinato in Costituzione.
Gli ulteriori passaggi
In seguito alla pronuncia della Corte costituzionale, si è pronunciato l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 352 del 1970; con l’ordinanza del 12 dicembre 2024, infatti, è stata dichiarata conforme alla legge la richiesta di referendum sull’intera legge (a differenza della richiesta di abrogazione parziale di quest’ultima).
A questo punto, la “palla” è passata nuovamente alla Corte costituzionale per il giudizio di ammissibilità del referendum, ai sensi dell’art. 2 della legge cost. n. 1 del 1953. Con la recente sent. n. 10 del 2025, il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibile il referendum per mancanza di chiarezza nel quesito, uno dei requisiti richiesti dalla stessa giurisprudenza costituzionale (v., tra le tante, la sent. n. 16 del 1978).
Effettivamente, i cittadini avrebbero potuto incontrare non poche difficoltà a comprendere l’oggetto del quesito, dovendo esprimere la propria preferenza in merito all’abrogazione della parte della normativa rimasta in vigore a seguito del “ritaglio” eseguito dalla Corte sulla legge n. 86 del 2024, quest’ultima avendo subito un significativo “restyling”.
Una particolarità di quanto è accaduto si può ravvisare nel fatto che la mancanza di chiarezza del quesito referendario eccepita dalla Corte costituzionale è stata dovuta non ai promotori del referendum ma alla stessa Consulta, ossia al suo intervento demolitorio avvenuto con la già cit. sent. n. 192, come d’altronde la più avvertita dottrina aveva prontamente rilevato. D’altra parte, quando la Corte si è espressa – attraverso la raffinata penna del giudice Pitruzzella – non doveva certo pensare a questo ulteriore effetto che avrebbe potuto provocare la decisione.
Peraltro, lungi dal poter considerare “pilatesca” la decisione dell’Ufficio centrale, c’è da dire che il controllo che, in prima battuta, effettua quest’ultimo è ben diverso da quello della Consulta. Non c’è quindi da meravigliarsi che l’uno e l’altro abbiano avuto un esito diverso.
E adesso che accade?
Messo da canto il referendum, occorre intanto chiedersi se ciò che resta della legge n. 86 è applicabile. Di certo, per la parte non interessata da incostituzionalità lo è. Come detto, però, “in piedi” è rimasto ben poco; e la stessa sent. n. 10, sopra richiamata, non lo nasconde.
A tal proposito, occorre precisare che le materie sulle quali si può chiedere l’autonomia c.d. “differenziata” sono state distinte in due tipi: materie LEP e materie no-LEP.
Le prime erano quelle, indicate nell’art. 3, II comma, della l. n. 86, rispetto alle quali il legislatore aveva delegato al Governo il compito di individuare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ex art. 117, II comma, lett. m (trattandosi di materie direttamente riconducibili ai diritti civili e sociali); poiché l’art. 3 è stato “affondato” dalla sent. n. 192, oggi, non si possono avanzare eventuali richieste di autonomia differenziata per il trasferimento di funzioni nelle materie ivi indicate, non potendosi individuare i LEP.
Le seconde, invece, sono le materie – tra quelle “differenziabili” – non inserite nel suddetto elenco, per le quali lo Stato non deve fissare i LEP. Per queste ultime, in teoria, le Regioni potrebbero chiedere autonomia differenziata. Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sent. n. 10 del 2025, ha di molto limitato tale possibilità, affermando che pure queste materie sono “incise dall’interpretazione fornita dalla sentenza n. 192 del 2024”, laddove si volesse chiedere il trasferimento di funzioni “che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”.
Pertanto, l’unica possibilità lasciata alle Regioni a statuto ordinario dalla legge n. 86 è quella di richiedere autonomia differenziata in materie “no-LEP” per il trasferimento di funzioni che “non incidano su un diritto civile o sociale” e purché “l’iniziativa regionale sia ‘giustificata alla luce del principio di sussidiarietà’”.
Quanto detto, però, non esclude affatto la possibilità che il legislatore possa, in futuro, porre mano ad una nuova legge volta ad attuare e precisare meglio il contenuto dell’art. 116, III comma, Cost.; di certo, però, non potrebbe fare “rivivere” norme della l. n. 86 dichiarate incostituzionali.
In ogni caso, poiché – come detto – la previsione costituzionale da ultimo richiamata non richiede di essere attuata necessariamente tramite una legge, in qualunque momento una Regione a statuto ordinario potrebbe avviare la procedura descritta nell’art. 116, III comma, Cost. e chiedere, appunto, “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”.
In conclusione
L’art. 116, III comma, Cost. si pone in diretta attuazione dell’art. 5 Cost.; infatti, il regionalismo “differenziato” non appare, a priori, in antinomia con il modello di regionalismo voluto dai costituenti, su ispirazione di don Sturzo, vero “padre” delle Regioni nonché “alfiere del regionalismo politico” (Antonetti). È necessario, però, com’è ovvio, che esso si realizzi in modo compatibile con lo “spirito” della Costituzione. Perché ciò accada la componente “cooperativa” deve rimanere prevalente rispetto a quella “competitiva” e si deve scongiurare la possibilità di dare vita ad un Paese che vada “a due velocità” ossia che aumenti il divario tra Regioni ricche e Regioni povere nella tutela dei diritti fondamentali, vera ratio dell’autonomia.
In conclusione, il regionalismo differenziato, per essere costituzionalmente ammissibile, non potrà che preservare l’intera tavola dei valori costituzionali e, in primis, quelli di solidarietà, di eguaglianza, di unità e di indivisibilità della Repubblica.