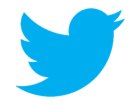Chi è vissuto nell’università italiana negli ultimi due decenni vede oggi come vi sia stato un vero e proprio sconvolgimento del sistema degli studi e degli insegnamenti.
Molta acqua è passata, velocemente, sotto i ponti, dai tempi dell’università-esamificio e dell’assoluta autodeterminazione dei docenti e ciò è stato sicuramente un passo in avanti.
La riforma apportata dalla legge 509 del 1999 ha rotto la rigidità degli studi istituzionali, introducendo una flessibilità dei percorsi formativi, in vista di un’adesione alle esigenze di una società in veloce trasformazione e nella fallace prospettiva di un mercato dell’occupazione capace di assorbire lavoro qualificato. Fu introdotto il credito formativo, che avrebbe dovuto ristabilire un nesso più coerente tra studio e docenza, e fu riconosciuta un’autonomia della governance, che avrebbe dovuto dare più responsabilità a facoltà e corsi di laurea, in rapporto alla formazione e alle competenze didattiche e scientifiche disponibili.
Se è vero che ne derivò una parcellizzazione dei corsi di studio e una moltiplicazione dei centri di spesa, la legge 509 introdusse un costume di valutazione dei costi e dei benefici nella gestione delle università sotto l’aspetto della didattica, lasciando ferme le conquiste ottenute nei precedenti decenni nell’organizzazione della ricerca. Sarebbe stato necessario correggere allora gli squilibri che s’erano determinati, accompagnando il processo della riforma, ma il legislatore pretese d’intervenire ulteriormente sui complessi e delicati processi di adeguamento che erano ancora in corso.
La riforma Gelmini del 2010 colpì i dipartimenti, che erano stati le istituzioni-simbolo della democratizzazione dei vecchi poteri accademici, un’istanza di libertà e di centralità della ricerca nel sistema universitario. Non furono aboliti, in quanto tali, i dipartimenti, ma furono stravolti con un procedimento che ha del tecnicamente “mostruoso”, giacché ad essi furono giustapposti i compiti di organizzazione didattica delle vecchie facoltà. Per un processo di drastico accentramento, dovuto contemporaneamente a esigenze di tagli di spesa e a una managerializzazione del governo degli atenei, si giunse a togliere poteri decisionali alla collegialità dei docenti. Si è assistito così ad accorpamenti improbabili delle istituzioni accademiche, determinati da pure ragioni di riduzione di costi, che hanno compresso gloriosi istituti e qualificati dipartimenti, dove s’erano sedimentate tradizioni scientifiche e culturali e nelle cui biblioteche s’erano accumulati patrimoni di sapere in una ricca gamma di settori della conoscenza. Perfino nelle denominazioni delle nuove strutture si è fatto fatica a trovare una coerenza, creando instabilità e disorientamento negli studenti.
Oggi, in un’accanita ricerca dell’innovazione, assistiamo a una paraziendalizzazione delle università, dove sono cresciuti i poteri dei rettori e degli organi economici del governo accademico e s’è instaurato un sistema centralizzato di valutazione della ricerca e della didattica, in termini di quantificazione e di efficienza estrinseca delle strutture. Ciò che è entrato in forte sofferenza è l’università come comunità umana e scientifica di studenti e di docenti.
A caratterizzare la fase attuale è un’insistenza nella ricerca dei cambiamenti nei curricula degli studi come nei criteri di accreditamento dei dottorati, in una programmazione sfrenata che, in certi settori, non riesce a trovare connessioni con il mercato del lavoro, nella moltiplicazione degli impegni di gestione da parte dei docenti, che impiegano parte del loro tempo in pratiche di adeguamento a decisioni imposte dall’alto e in una meccanica rispondenza ai controlli continui di una burocrazia resa invadente dalla tecnologia informatica. Il docente universitario era un tempo uno studioso che trasmetteva il suo sapere agli studenti. Oggi il docente ha tre doveri fondamentali: produrre pubblicazioni, svolgere l’attività didattica e assumere impegni di terza missione, vale a dire prendere iniziative di promozione e di visibilità del proprio ateneo e procacciare finanziamenti della ricerca. Il lessico corrente nelle università, dove è tutto un fiorire di “innovazione”, di “offerte”, di “erogazione”, di “prodotti”, di “presidi di qualità”, riflette passivamente una logica dell’impresa che è l’esatto contrario dell’originalità culturale che dovrebbe fare dell’università e di tutta l’istruzione uno dei fattori costitutivi della società e della cittadinanza.
Sembra venir meno, nella dimensione tecnologica, il senso del tempo della formazione e dei fattori umani che animano il mondo degli studi